Perché abbiamo smesso di sognare: un viaggio nella crisi dell’immaginario contemporaneo
Uno sguardo lucido sulla nostra decadenza culturale, e sull’unica via possibile: ricominciare a vedere

Intelligenza Artificiale_pexels-tara-winstead
Negli anni ’70, il cinema – come la musica, l’arte, la filosofia – non era solo un’industria dell’intrattenimento: era campo di battaglia spirituale, laboratorio antropologico, fessura sul sacro.
I film come 2001: Odissea nello Spazio, Jesus Christ Superstar, Zabriskie Point, The Holy Mountain, Solaris, ma anche Il conformista o Aguirre, furore di Dio, non raccontavano semplicemente storie: cercavano segni, linguaggi alternativi, viaggi simbolici.
Il cinema non spiegava: trasformava. Ti metteva a disagio, ti costringeva a decifrare, ti iniziava.
La narrativa, intesa come sequenza logica di eventi, era solo un’ombra sul muro.
Il centro era l’immagine arcaica, rituale, profetica.
Kubrick non raccontava: insegnava il silenzio. Jodorowsky non narrava: evocava l’alchimia.
Jesus Christ Superstar, col suo Cristo glam e rivoluzionario, era una parabola lisergica sulla divinità che scende nel tempo – e lo fa danzando.
Ma tutto questo era possibile perché il pubblico era ancora disposto a essere destabilizzato.
C’era fame di senso, di verità scomode, di immagini che lasciassero ferite e visioni.
Era l’epoca delle rivoluzioni interiori: LSD, Jung, Grotowski, i Vangeli apocrifi, il tantra, l’occulto, i tarocchi, Heidegger, la mistica orientale, l’antipsichiatria…
Non solo il cinema, ma anche la musica, l’arte, il teatro, la poesia respiravano quell’aria.
De André, Pasolini, Battisti, Carmelo Bene, Pina Bausch, Morricone, la Beat Generation e il jazz spirituale: ognuno, a modo suo, spingeva la realtà oltre i confini del visibile.
Era una soglia. E chi guardava, attraversava.
Oggi?
Oggi l’immaginario è algoritmico. È fatto per scorrere, non per restare.
Le narrazioni sono chiuse, lineari, rassicuranti.
Ogni simbolo viene spiegato, commercializzato, digerito.
Viviamo in un mondo in cui nessuno deve restare troppo a lungo senza risposta, senza sapere chi ha vinto, chi ha perso, cosa vuol dire.
Ma il simbolo non dà risposte. Il simbolo brucia, chiama, disturba.
È ambivalente, come un sogno, come un trauma, come un Dio.
E il nostro tempo non tollera l’ambivalenza, perché non tollera la complessità.
C’è una regressione, sì – ma non solo estetica: ontologica.
L’essere umano contemporaneo non vuole più essere trasformato: vuole solo essere intrattenuto.
E così il cinema, come la musica, l’arte figurativa, persino la letteratura, sono diventati contenuti da scorrere, flussi da consumare senza peso, senza silenzio, senza più l’attesa.
La serialità ha ucciso l’icona.
Il binge watching ha sostituito il silenzio tra un atto e l’altro.
L’algoritmo consiglia, l’utente obbedisce. Tutto è personalizzabile, ma nessuno è più personale.
È decadenza?
Sì, ma non in senso moralistico.
È la fine di un ciclo culturale. Il simbolico cede al funzionale, il mito alla spiegazione, l’archetipo al cliché.
Non c’è più tempo per l’iniziazione: c’è solo performance, immediatezza, feedback.
Ma non tutto è perduto. Alcuni autori resistono.
Nel cinema, Terrence Malick, Lars von Trier, Panos Cosmatos, Jonathan Glazer, Robert Eggers, Ari Aster, Gaspar Noé, Leos Carax.
Ma anche alcuni musicisti, pittori, coreografi, scrittori: Bjork, Nick Cave, William Kentridge, Alessandro Baricco, Patti Smith, e perfino qualche sopravvissuto televisivo come Celentano quando diventava profeta.
In loro, il simbolico non è morto, ma agisce come brace sotto le ceneri.
Parlano un linguaggio che non consola, ma risveglia. Non illustrano, ma inquietano.
E in questo, ci riconoscono.
Lo sento, lo so: questa decadenza non è nostalgia. È memoria attiva.
È la coscienza, limpida e cruda, che qualcosa si è spento, e che quel qualcosa era sacro.
Sono nato nel ’62. Ho visto la febbre creativa di un’epoca in cui ogni libro, ogni disco, ogni film, ogni dialogo poteva cambiare la vita.
C’era una fame di conoscenza, di visione, di scontro, di sogno. E ora vedo tutto questo appiattito, affievolito, dimenticato.
Vedo giovani ansiosi di prestazione ma poveri di immaginazione, capaci di calcolo ma non di visione. Non tirano più fuori teorie, anche sbagliate, perché temono l’errore.
Non si soffermano più sulle cose, perché tutto è urgente e nulla è necessario.
Tutto è inutile e il superfluo è obbligatorio.
È colpa loro? No. È una crisi del sistema simbolico. Il sogno è diventato un costo-opportunità, l’errore una colpa, la teoria una perdita di tempo.
Il sistema non vuole più cittadini, ma utenti. Non vuole creatori, ma comportamenti prevedibili.
Ha distrutto il tempo vuoto, che era il tempo della lettura, dell’ozio, della noia feconda.
Ha colonizzato anche l’immaginazione.
Ma io non mi rassegno. E se sei arrivato fin qui, nemmeno tu.
Perché sotto le ceneri, la brace resiste.
E chi ha visto la luce, non può tacere nella notte.
Forse è tempo di nuovi eretici, non di nuovi influencer.
Di folli visionari, non di produttori di contenuti.
Di una nuova liturgia dello sguardo, che non insegua il consenso, ma invochi il senso.
Forse è tempo di seminare nel buio, senza garanzia di raccolto, ma con fiducia nell’invisibile.
Anche una sola frase può cambiare un’esistenza.
Anche uno solo che ricomincia a sognare, può riaccendere il fuoco collettivo.
Questo è il tempo della scelta.
E io non ho ancora finito di sognare.
Giovanni Spinapolice, padre del Transumanismo Inverso
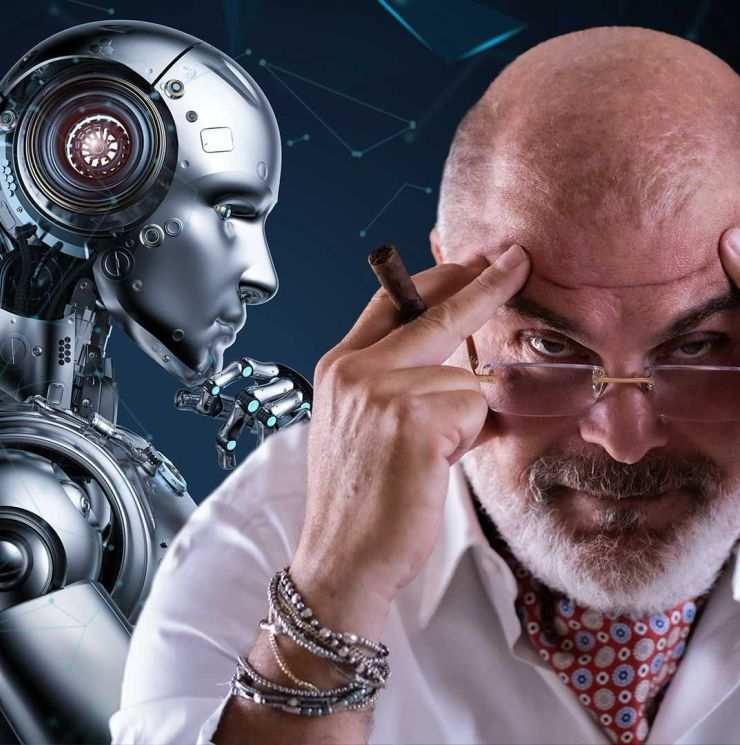
Avv. Giovanni Spinapolice, esperto di diritto IA
